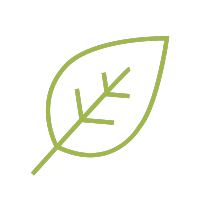Come rendere la DEI parte della cultura aziendale: intervista a Valentina Dolciotti
Come rendere la Diversity, Equity e Inclusion (DEI) parte integrante della cultura aziendale? Lo abbiamo chiesto a Valentina Dolciotti, fondatrice del magazine DiverCity. Valentina ci ha parlato della DEI come di un percorso fatto di sfide, stereotipi e cambiamenti possibili, a partire da ascolto, competenza e coraggio.
Ci racconti brevemente il tuo percorso professionale e la tua esperienza in DEI?
Il mio percorso professionale nell’ambito della Diversity, Equity & Inclusion è iniziato tredici anni fa, nato da un interesse personale per le tematiche di genere. In quel periodo, ad esempio, collaboravo con la Libreria delle Donne, a Milano, per la quale scrivevo articoli focalizzati sulla questione femminile.
Nel 2012 ho intrapreso un percorso più strutturato e formale: mi sono licenziata dal mio lavoro (lavoravo da diversi anni nel sociale, occupandomi di supporto ad adulti con disagio psichiatrico e di ragazzi/e adolescenti), ho aperto la partita IVA, ho approfondito gli studi e ho iniziato a propormi come consulente e formatrice sui temi DEI. Questa scelta ha coinciso con un momento di forte cambiamento personale, ovvero la maternità, che ha ulteriormente rafforzato il mio impegno verso le tematiche legate all’inclusione e alla parità.
Da un punto di vista formativo, ho una laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, che mi ha permesso di sviluppare una base pedagogica e una forte attenzione alle tematiche educative e sociali che, nel tempo, ho imparato essere profondamente legate al tema della DEI. Ho frequentato nel 2012, un corso post laurea – Uguaglianza attraverso le regole di genere – presso la Facoltà di Giurisprudenza. Mentre nel 2013-2014, ho conseguito il master in Diversity Management a Roma che mi ha fornito ulteriori strumenti, teorici e operativi, per accompagnare persone e organizzazioni in percorsi di cambiamento inclusivo.

Secondo te, qual è il primo passo che un'azienda dovrebbe fare per sviluppare internamente il tema DEI?
Il primo passo, secondo me, è capire davvero come sia composta la propria azienda. Serve una fotografia oggettiva, numerica, delle diversità presenti: generi, età, lingue, culture, religioni, disabilità... Solo così ci si rende conto che, spesso, c’è molta più diversità di quanto si immagini e, allo stesso tempo, solo così si riescono a progettare azioni concrete, che rispondono a bisogni reali, non astratti.
Poi c’è un aspetto che spesso si sottovaluta: tornare a studiare. Acquisire strumenti, approfondire, confrontarsi anche con chi lo fa da tempo. Guardare alle aziende, fare benchmarking, è un’altra prassi importante che bisognerebbe acquisire per evitare improvvisazioni e costruire invece un percorso solido, che abbia un impatto vero.
In quali ambiti DEI (es. disabilità, generazioni, etnie, generi, età, LGBTQIA+) noti ancora resistenza o poca visibilità nel contesto aziendale italiano?
Il tema di genere è sicuramente quello più visibile, e negli ultimi anni anche quello delle generazioni sta guadagnando attenzione. Abbiamo iniziato da poco a dare nomi alle generazioni e a riconoscere che, in azienda, convivono età, vissuti e approcci molto diversi.
Ci sono altri ambiti che restano più sommersi. Penso ad esempio alle disabilità cosiddette invisibili, che sono ancora poco raccontate, poco conosciute e spesso stigmatizzate. Parlo di neurodivergenze, difficoltà motorie lievi, o condizioni che non si vedono a occhio nudo, ma che hanno un impatto enorme sulla vita lavorativa (e non solo) delle persone.


Anche il tema delle religioni è poco affrontato. Come se si potesse parlare di etnie e culture diverse senza considerare che queste portano con sé anche un’identità religiosa, riti, pratiche! È un pezzo fondamentale di noi, che non andrebbe tralasciato.
Riguardo la comunità LGBTQIA+ la situazione è un po’ più complessa. Negli anni passati c’è stato un impegno crescente, ma oggi si percepisce una certa erosione, un rallentamento. In parte ricalca quello che è successo negli Stati Uniti, dopo l’elezione di Trump. Anche in Italia, tra politiche e sentenze discutibili, la direzione non è chiarissima. Penso, per esempio, alla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha legittimato il riconoscimento di bambini/e nati da due mamme, ma ancora non c’è nessuna apertura per le famiglie formate da due papà.
Le aziende, inevitabilmente, si muovono dentro questo ecosistema. Le quotate e le pubbliche hanno a che fare con investitori, pressioni politiche, nomine governative… Questo condiziona, ma tante grandi aziende, in passato, hanno avuto il coraggio e la lungimiranza di anticipare i cambiamenti legislativi che poi sono arrivati. Penso a quelle che hanno introdotto il congedo matrimoniale per coppie dello stesso sesso, quando ancora le unioni civili non erano Legge.
Oggi, lo capisco, esporsi è più difficile. C’è meno chiarezza, serve maggior coraggio.

Cosa dovrebbe cambiare per rendere la DEI davvero strutturale, e qual è la difficoltà più grande che si incontra nel coinvolgere la leadership in un percorso DEI?
Parto dalla seconda domanda. La fatica più grande è modificare la convinzione che la DEI non abbia ricadute pratiche, concrete anche sul business. Esistono dati, evidenze, benefici reali. Ma alcuni Board sono ancorati a un’idea di lavoro un po’ anni ’90, basata su controllo, presenza fisica, costante, performance esasperata. La DEI, invece, propone tutt’altro: fiducia, responsabilizzazione, flessibilità. È un cambio di paradigma. Un approccio culturale completamente diverso.
Con la DEI non si controlla, si responsabilizza; non si impone, si costruisce insieme. È un investimento a 360° che scardina modelli vecchi, e funziona solo se davvero si ha voglia di cambiare, innovare.
E proprio per questo, per rendere la DEI strutturale e diffusa, serve che diventi trasversale. Eccoci alla prima domanda. Se resta un approccio verticale (top-down o down-top poco cambia), limitata a poche persone, a un singolo ufficio o funzione, è fragile. Basta poco per farla saltare. Ma quando diventa parte della cultura aziendale, dei comportamenti di tutti/e, dei modi di pensare, se entra nella testa delle persone, allora non puoi eliminarla. Nemmeno con un decreto presidenziale, per dire. Ed è lì che succedono cose belle.
Un’ultima cosa importante è darsi tempo. Non si cambia la cultura con “un workshop ogni tanto”. Il cambiamento vero ha bisogno tempo, di formazione continua, progetti ampi, visioni a lungo termine. Il rischio, altrimenti, è di nuovo fare washing: dichiarare un cambiamento che non c’è, riempire il calendario aziendale di momenti “spot” senza far nulla il resto dell’anno. La DEI non è un evento: è un processo.

Quali sono gli errori più frequenti che le aziende potrebbero commettere quando dichiarano di voler lavorare su diversità, equità e inclusione?
Gli errori sono tantissimi. Uno dei più frequenti è dichiarare di lavorare su diversità, equità e inclusione, sia verso l’interno che verso l’esterno, prima ancora di aver fatto qualcosa di concreto. È un approccio che rischia di indebolire la credibilità dell’azienda e dell’intero percorso, perché le persone si accorgono subito quando dietro le parole non ci sono i fatti.
Altro errore comune è formare tutti e tutte ma non coinvolgere da subito “la prima linea”. Capita spesso che si inizino a formare le persone dell’azienda, ma senza avere a bordo il top management. Il rischio è che la popolazione aziendale inizi a maturare consapevolezze, a cambiare sguardo… mentre la leadership resta indietro. Si crea uno squilibrio pericoloso. La formazione, invece, dovrebbe essere fatta contemporaneamente a tutti i livelli.
Poi c’è il tema del cosiddetto “washing”. Forse non propriamente un errore, è sicuramente segnale che qualcosa non torna. Se un’azienda comunica inclusività, ma al suo interno non si muove nulla, il rischio è di essere smascherata come poco autentica.
Altra ingenuità che vedo spesso è pensare di poter gestire tutto da soli, senza l’aiuto di esperti/e o senza formarsi. Questo credo nasca da una confusione tra la sensibilità personale e la competenza professionale. In tutte le aziende ci sono persone sensibili alle tematiche DEI - ed è un’ottima cosa, un punto di partenza! - ma non basta. Ad esempio, avere un collega membro della comunità LGBTQIA+ non significa che questa persona sia automaticamente in grado di gestire il tema. Il vissuto è importante, certo, ma serve anche un linguaggio corretto, conoscenza, struttura. Altrimenti si rischia di trasformare un’occasione formativa in una condivisione solo emotiva e anche, potenzialmente, dannosa.
Infine, talvolta pensiamo che la DEI sia un tema “nuovo”. In realtà ha una storia lunghissima, soprattutto negli Stati Uniti, dove si lavora su questi argomenti da inizio Novecento. IBM ha assunto il primo dipendente con disabilità nel 1914. Non possiamo improvvisare: serve studiare, serve capire la storia del diversity management, e soprattutto serve trattarlo per quello che è: un tema che tocca in profondità l’identità delle persone. E questa va maneggiato con cura, rispetto e competenza.
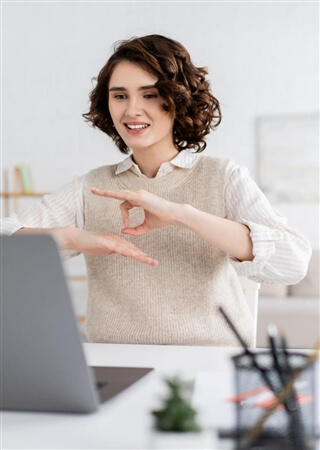

Puoi condividere l’esempio di un’azienda (anche anonima) che ha realizzato un intervento in ambito DEI che ha portato a un cambiamento significativo?
Sì, mi viene in mente un intervento che abbiamo realizzato lo scorso anno con Nespresso. Abbiamo ideato un esperimento sociale, con la scusa di una formazione rivolta a tutte le persone di sede, divise per team. In realtà, la formazione era “finta”, un pretesto, guidata da due attori/attrici. Lo scopo non dichiarato era mettere le persone di fronte alle dinamiche che viviamo ogni giorno in ufficio.
In pratica, durante l’incontro, il formatore (attore) più attempato si rivolgeva alla formatrice (attrice) più giovane con sottili “battute” sessiste, infarciva le frasi di stereotipi, commenti fuori luogo, frasi che tutti/e conosciamo e che quasi sempre vengono liquidate con un “ma dai, era solo una battuta!”.
È stato davvero disruptive. Nespresso ha un buon livello di maturità in termini di inclusione. Le persone si guardavano attorno sbigottite; c’erano telecamere e microfoni nascosti e abbiamo osservato: c’era chi interveniva, chi no, chi si sentiva a disagio, ma rimaneva in silenzio. Dopo lo svelamento degli attori, tanti/e erano scossi, arrabbiati, delusi da sé. Alcuni raccontavano di aver mandato whatsapp ai colleghi, altri scrivevano a casa, colpiti dal fatto di non essere riusciti intervenire davanti a tali discriminazioni. Il dialogo tra l’attore e l’attrice era volutamente scorretto, ma sottilmente studiato nei minimi dettagli. Perché quel tipo di dinamiche, che ti colpiscono, ti paralizzano o ti lasciano nell’ambiguità, sono le stesse che tutti e tutte abbiamo vissuto, in un modo o nell’altro: da protagonisti, da vittime o da spettatori e spettatrici.
Alla fine, il messaggio era chiaro: se vogliamo che le cose cambino, dobbiamo impegnarci tutti/e, ogni giorno, in ogni gesto e parola. Anche in quelle piccole. Anche solo iniziando un’email dicendo “ciao a tutte e a tutti”.
Riassumendo: capire chi sono le persone che lavorano con te e di cosa hanno veramente bisogno. Formarsi. Studiare. Affidarsi a chi ha qualche competenza in più. Costruire percorsi ragionati che non siano uguali per tutti/e, ma calibrati davvero su chi hai davanti. Perché dare la stessa cosa a tutti/e non significa affatto rispondere a un bisogno, non è DEI e non è nemmeno democratico. Dare a ciascuno/a ciò di cui ha bisogno, invece lo è.
Mettere tutti e tutte nelle condizioni di lavorare al meglio, esprimere talento e potenzialità, essere fieri delle proprie peculiarità, sentirti parte integrante e utile della propria azienda.

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI